Da I fiaschi
di Francesco Targhetta
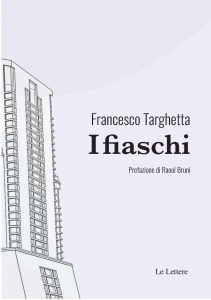 Viene ripubblicato in questi giorni il primo libro di poesie di Francesco Targhetta, I fiaschi, la cui edizione originale risale al 2009 ma a cui è stata ora aggiunta una sezione nuova, intitolata Fondi e composta di versi inediti scritti tra il 2003 e il 2011. Insieme a Le istruzioni del gioco di Roberta Durante e a Il bianco della luna di Nino De Vita, il volume di Targhetta è uno dei tre titoli in uscita simultanea che inaugurano la nuova collana di poesia «novecento/duemila» diretta da Diego Bertelli e Raoul Bruni per l’editore Le Lettere. Lo stesso Bruni aveva prefatto I fiaschi nel 2009 e ha aggiornato la sua presentazione alla nuova edizione inquadrando, tra l’altro, la raccolta “come irriverente controcanto a una certa idea oleografica di Veneto” che anticipa “in certo modo romanzi come Cartongesso (2014) di Francesco Maino ed Effetto domino (2015) di Romolo Bugaro” oltre che il “fortunato romanzo in versi (Perciò veniamo bene nelle fotografie)” e quello “in prosa (Le vite potenziali)”, editi da Targhetta nel 2012 e nel 2018.
Viene ripubblicato in questi giorni il primo libro di poesie di Francesco Targhetta, I fiaschi, la cui edizione originale risale al 2009 ma a cui è stata ora aggiunta una sezione nuova, intitolata Fondi e composta di versi inediti scritti tra il 2003 e il 2011. Insieme a Le istruzioni del gioco di Roberta Durante e a Il bianco della luna di Nino De Vita, il volume di Targhetta è uno dei tre titoli in uscita simultanea che inaugurano la nuova collana di poesia «novecento/duemila» diretta da Diego Bertelli e Raoul Bruni per l’editore Le Lettere. Lo stesso Bruni aveva prefatto I fiaschi nel 2009 e ha aggiornato la sua presentazione alla nuova edizione inquadrando, tra l’altro, la raccolta “come irriverente controcanto a una certa idea oleografica di Veneto” che anticipa “in certo modo romanzi come Cartongesso (2014) di Francesco Maino ed Effetto domino (2015) di Romolo Bugaro” oltre che il “fortunato romanzo in versi (Perciò veniamo bene nelle fotografie)” e quello “in prosa (Le vite potenziali)”, editi da Targhetta nel 2012 e nel 2018.
Si presentano di seguito alcune poesie della sezione Fondi, ringraziando l’autore e l’editore per avercene dato la possibilità.
Il ritorno dal luogo di lavoro
Gli schiocchi dei cancelli alle sette
e gli sportelli sbattuti con sollievo
o rancore, le chiavi ben sfregate
tra le dita a tramestare supposte
libertà: ma non c’è niente,
io dico, che ci dispensi dal favore
che paghiamo, ogni sera, al padrone,
con questo sfoggio di felicità?
La camicia buona
Ti metti la camicia buona, alleni la mano
a stringere con franchezza, sforzi
battute che allietino il clima,
ed esegui il tuo compito con impeccabile
grazia.
Prima di abbandonarti al sonno,
la sera, macini insulti e doverose
stoccate, ti difendi con rabbia
dalle circostanze, ed incarni in fantasie
di sabbia la persona, solida, che non riesci
a essere, e che accusi gli altri,
tuoi specchi invecchiati,
accusi gli altri di voler sopprimere.
Al semaforo
Ci piace stare in fila al semaforo,
al crepuscolo, imboccata la solita
corsia: si fermano per noi, solo
un attimo, il panificio e la copisteria,
il cono gigante del gelataio,
l’arredabagni, l’edicola. Tamburelliamo
sul volante con orgoglio, ostentando
sullo specchietto un angolo d’occhio
disteso, amico, che fissa di nuovo,
ogni sera, con puntine arrugginite,
lo scenario delle cose familiari
e la pietosa quotidiana alleanza
tra noi e loro, rispettata con onore
e senza strette di mani.
Ci piace meno ripartire, al verde:
il quartiere si perde nel buio
dei lampioni, e fingerla ancora,
domani, la vita,
inizia a sembrarci quasi un lavoro.
La collaboratrice
Camilla come lavoro collabora:
la incontri a cene di amici in comune
sul suono infranto dei tagliaerba,
e timida ti spiega tritando le rape
dei centri giovani e associazioni,
dei corsi che tiene di italiano
per gli immigrati dei cantieri edili,
le stanghette degli occhiali che ballano
sui suoi tocchi continui con l’indice
e risate al barbecue spente
su vuoti a cui poi ripensare.
Quando le chiedono come va,
risponde sempre «discretamente»
oppure, di rado,
«non c’è male».
I contributi
La precisione dei separé in ufficio
e le chimiche linee della metro
tra gli acciai sopra i vetri dei palazzi
incassati nei pannelli a quadrati
o il liscio che aderisce alle pareti
come il quarzo contro gli archivi
e le mensole, non lo schiudono,
nemmeno se il sole la stringe elettrica
la grigia spianata della moquette,
il motivo intrinseco del krapfen al bar,
dell’annacquato ginseng di domani,
di una serata che sfibra le tende
per sbatterti addosso il cibo di ieri,
e le foto del mare, i visi sdruciti
degli amici lontani.
Attorno al tuo cerchio
c’è sempre spazio per combattere
l’aria o franare spediti, o al fine
convincere, se c’è del senso,
almeno un paio dei propri clienti,
almeno altri
rispetto a te
più decisi.
Il pappagallo
In quattro allineati a guardare il soffitto
estranei reciproci e pure a noi stessi
nel silenzio dei giorni più lunghi
con il sole che filtra alle nove di sera
e quattro flebo su noi e quattro seggiole
rimaste vuote come i nostri stomaci
e come le bocche che tacciono dure.
Togli i cerotti a tutti i disgusti, metti
l’ago nelle paure, drena come sangue
la solitudine che sbatte come trottola
tra i muri celesti, perché trovarsi
deserti, secchi come sterpi, aiuta
a rimettersi nelle proprie vesti
senza la vergogna di essere inermi.
Due letti più in là premono il tasto
mentre il sole sulle imposte ha sviato
il giallo: arriva l’infermiere, zitto come
noi, a svuotare nel cesso il pappagallo.
Scheda dell’Atto impuro
- DATA PUBBLICAZIONE:
- 6 novembre 2020
- CATEGORIA/E:
- Azioni
- TAG:
- Francesco Targhetta
Naviga negli Atti
Atti correlati
TaggAt(t)i
.noibimbiatomici Ade Zeno Alessandra Carnaroli Alessandro De Roma Andrea Inglese Atti impuri Berlino Berlusconi Elena Mearini Elisa Alicudi Elisa Baglioni Enrico Carovani fabbrica Fabrizio Bajec Francesco Ruggiero Giorgio Falco Intervista lavoro Leo Winkler letteratura Luigi Socci Marco Candida Marco Mancassola Marino Magliani musica Nadia Agustoni noi bimbi atomici NUR fotografia p.s.lab poesia poesiatotale poesia totale poetry slam prosa racconto Recensione Russia Sergio Garau Slam sparajurij Stefano Raspini Tommaso Ottonieri torino unione culturale Wir Atomkinder
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.




















0 commenti
Vai al modulo commenti | Abbonati ai feed dei commenti | Trackback uri